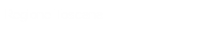Raul Fontanelli nato a Empoli (FI) il 27/10/1901.
Negli anni venti si sposa con Concetta Posarelli nata nel 1904 con la quale ha tre figli, Franca nata nel 1930, Atusca nata nel 1934, Giancarlo nato nel 1938.
La famiglia, dopo aver abitato nel centro di Empoli, negli anni trenta si trasferisce nel Borgo di Pontorme, frazione di Empoli.
Raul lavorava nella vetreria Taddei, i momenti non erano dei migliori, comunque con il suo lavoro la famiglia riusciva dignitosamente a tirare avanti.
Verso la fine del 1943 a Empoli ci furono dei bombardamenti da parte degli alleati.
Molte bombe caddero in varie zone della città e provocarono molti morti.
Nel gennaio del ‘44 durante un bombardamento fu colpita anche la vetreria dove Raul lavorava e otto operai rimasero uccisi.
In seguito a questi avvenimenti molti abitanti furono costretti ad andare sfollati nelle campagne, in luoghi più sicuri.
Anche la moglie Concetta con i tre figli si trasferirono nella frazione di Botinaccio, in collina sopra a Montelupo.
C’era una chiesa e delle case coloniche libere, gli sfollati erano tanti e venivano anche da diverse località della Toscana.
Per poter andare a lavorare, Raul dovette rimanere nella casa di Pontorme, perché la località dove era sfollato il resto della famiglia era troppo lontana dal posto di lavoro.
Nel marzo del 1944, come in tutte le città industriali del centro e del nord Italia anche, ad Empoli viene proclamato lo sciopero generale, al quale parteciparono anche gli operai della vetreria Taddei e quelli di tutte le fabbriche della zona, con il coinvolgimento di buona parte della popolazione.
Il giorno 4 marzo ebbe luogo lo sciopero generale contro il regime nazifascista, ma Raul, pur essendo un convinto antifascista, non poté parteciparvi attivamente, perché era ammalato, infatti spesso soffriva di attacchi di asma, dovuti alle condizioni non proprio delle migliori all’interno del posto di lavoro.
Al mattino presto del 8 marzo, Raul si trovava a casa, quando due colleghi di lavoro passarono a chiamarlo per andare a lavorare (come è stato poi riferito alla moglie da una vicina di casa).
Raul, quasi avendo un presentimento, disse loro che era un po’ preoccupato per quello che poteva succedere in seguito allo sciopero dei giorni precedenti e non aveva intenzione di andare a lavorare e che avrebbe approfittato dell’occasione per andare a trovare la famiglia sfollata.
Tuttavia, alla fine i due compagni di lavoro lo convinsero ad andare insieme a loro e fu così che quella mattina si presentò regolarmente in fabbrica.
Poco dopo l’inizio del turno di lavoro, all’incirca alle 5 del mattino, si presentò il capofabbrica con una lista di nomi ed uno alla volta gli operai furono chiamati ed invitati ad andare in ufficio dove c’era l’impiegata che chiedeva il nome, che subito cancellava dalla sua lista e li invitava ad uscire.
Fuori li aspettavano dei fascisti con dei camion, che li portarono nella caserma della Guardia Nazionale Repubblicana in Via Jacopo Carrucci.
Là trovarono altre persone che erano state arrestate, chi a casa e chi per strada in tutti erano 55. Nella vetreria ne furono presi in 26.
Gli arresti sono stati eseguiti dai fascisti repubblichini o dalle forze dell’ordine italiane, come è avvenuto nella maggior parte delle deportazioni politiche.
Solo successivamente sono stati consegnati ai nazisti.
Negli arresti alla vetreria Taddei, come in altre fabbriche, c’è stata anche una grossa responsabilità da parte degli industriali.
Questi avevano stilato le liste degli operai, che avevano partecipato allo sciopero, in modo da permetterne l’arresto.
Nel caso della Taddei li avevano addirittura consegnati direttamente ai fascisti.
Dalla caserma con due pullman della Lazzi, che erano stati requisiti, furono trasferiti a Firenze, prima alla sede degli allievi sottufficiali dei Carabinieri e da lì, visto che il comandante non li volle prendere in carico, furono portati a Villa Triste dove operava la famosa banda Carità, autrice di torture, sevizie e conseguenti uccisioni.
Ma anche lì rimasero per poco tempo.
Infatti poi furono trasferiti alle Ex Scuole Leopoldine in Piazza S. Maria Novella (adesso Museo del Novecento) che erano state requisite nei giorni precedenti.
Alle Ex Scuole Leopoldine trovarono gli arrestati provenienti prevalentemente dalle grandi industrie Firenze (come la Galileo e la Pignone) e dalle industrie laniere di Prato, in tutti erano poco meno di quattrocento.
Tuttavia furono molti gli arrestati perché già segnalati come antifascisti e oppositori del regime o semplicemente perché si trovavano nel posto sbagliato nel momento sbagliato.
Secondo alcune testimonianze, un ufficiale delle SS tedesche disse al comandante dei fascisti italiani di lasciare andare i prigionieri, visto che la maggior parte erano degli innocui padri di famiglia, ma lui rispose di no dicendo che gli arrestati erano una “pericolosa” massa di scioperanti.
Furono poi trasferiti alla stazione di S. Maria Novella di Firenze e passando dalla rampa sul lato di via Alamanni, furono portati al binario 1 e avviati su carri bestiame piombati, con la scritta assolutamente falsa “Lavoratori Volontari per la Germania”.
La moglie Concetta e i figli, non risiedendo ad Empoli, erano inconsapevoli di quello che stava succedendo.
Solo dalle testimonianze dei pochi superstiti, hanno saputo solo in seguito quanto era accaduto intorno all’8 marzo ‘44.
Durante il viaggio vennero buttati dei biglietti dal treno con l’intento di fare arrivare notizie ai familiari.
Ad un certo punto il treno si fermò in aperta campagna e le SS li ammonirono dicendo che se avessero visto uscire da un vagone un altro biglietto li avrebbero fucilati tutti.
Addirittura alcuni di questi biglietti, non si sa come, ma furono recapitati in qualche maniera alle famiglie.
Durante il viaggio fu data una scatoletta di pasta di pesce da mezzo chilo per 10 persone, che era molto salata, e 250 grammi di pane a testa.
Il viaggio durò tre giorni e tre notti senza mai bere, e i deportati morivano letteralmente di sete.
Al Brennero cercò di intervenire la Croce Rossa Internazionale per dare la sua assistenza, ma non ci riuscì, perché le SS impedirono ogni gesto di solidarietà, dicendo che non si trattava di prigionieri militari bensì di volgari banditi.
Il treno riprese la sua corsa finché arrivò a Mauthausen l’11 marzo 1944, dopo tre giorni di estenuante viaggio.
Dal racconto della moglie Concetta, si è saputo che lei stessa era andata a riprendere in fabbrica la giacca di Raul qualche tempo dopo.
Quindi i deportati, almeno quelli della vetreria, arrivarono a destinazione in maniche di camicia, così come erano all’interno della fabbrica al momento dell’arresto.
A Mauthausen, nonostante si fosse già a marzo c’era ancora molta neve e faceva molto freddo.
Passando in mezzo al paese, furono trasferiti a piedi dalla stazione al campo di concentramento di Mauthausen, che è una fortezza che si trova a cinque chilometri dal centro abitato.
Nonostante che, dopo la guerra, si volesse far credere il contrario, gli abitanti di Mauthausen sapevano benissimo dell’esistenza del campo.
Giunti al campo cercavano di dissetarsi con la neve e le SS li esortavano a non farlo, perché era molto pericoloso e sarebbero morti.
Quindi spogliati nudi sul piazzale dell’appello, poi depilati e portati alle docce, dove veniva mandata alternativamente acqua caldissima e freddissima.
Quando i malcapitati si spostavano verso l’esterno, allontanandosi dalle docce, venivano spinti a colpi di manganello di nuovo sotto l’acqua (i manganelli erano di gomma con all’interno fili di acciaio, facevano male senza lasciare tracce).
Veniva poi data la divisa e le calzature che consistevano in zoccoli di legno.
Successivamente veniva registrato il numero di matricola, rigorosamente in ordine alfabetico, i nazisti erano precisi e meticolosi nel registrare la scheda con tutti i dati anagrafici.
Raul, come tutti gli altri deportati del trasporto, fu classificato con la categoria Schutzhaftlinge (deportato per motivi di sicurezza) e gli venne dato il triangolo rosso di deportato politico, da mettere sulla casacca insieme al numero di matricola.
Da quel momento in poi Raul, come tutti gli altri deportati, non avrebbe più avuto un nome e cognome ma sarebbe stato identificato con il numero 57126.
Avveniva così la spersonalizzazione e l’umiliazione dell’individuo.
Durante gli estenuanti appelli sul piazzale, sarebbe stato chiamato con questo numero pronunciato in tedesco e se non rispondeva perché non capiva, come senz’altro succedeva specialmente i primi tempi, sarebbero state botte con il manganello o anche peggio.
Dopo una quindicina di giorni di quarantena, trascorsi in luogo apposito del campo, il 25 marzo, insieme a molti altri compagni, Raul fu trasferito nel sottocampo di Ebensee.
Molti altri furono destinati al sottocampo di Gusen.
Ad Ebensee fu assegnato al blocco: Zement (nome in codice), praticamente il lavoro consisteva nello scavo di gallerie, che sarebbero poi state adibite alla costruzione dei missili V2.
Fortunatamente il progetto V2 non andò in porto, altrimenti, molto probabilmente la guerra avrebbe potuto avere un esito diverso.
Raul, è morto ad Ebensee il 30 maggio 1944, dopo 81 giorni di lavoro schiavo all’età di 42 anni.
Sembra sia stato colpito da dissenteria o sia rimasto ferito durante lo scavo delle gallerie.
Comunque portato in infermeria, la morte dovrebbe essere stata provocata da una iniezione di benzina al cuore.
La data della morte di Raul è testimoniata anche dal documento attestante il decesso, una sorta di certificato di morte, reperito nell’Archivo Arolsen, che è un centro internazionale di documentazione, che riguarda la deportazione nei campi nazisti.
Come detto prima, i tedeschi erano molto precisi e meticolosi, lucidi nella loro follia, documentavano tutto.
Il documento, che riporta anche l’ora e i minuti precisi della morte, sembra quasi certificare un decesso per cause naturali.
Dietro questa banalizzazione del male c’era però una famiglia lasciata nello sgomento, che non ha saputo niente di cosa era successo al proprio congiunto per più di un anno.
Infatti la famiglia ha saputo ciò che era successo, solo quando sono tornati i superstiti, peraltro pochissimi, dei 26 deportati della vetreria ne sono tornati solo 3.
Il trasporto 32, quello partito da Firenze con destinazione Muathausen, è stato tra quelli con la più alta percentuale di mortalità, infatti hanno fatto ritorno a casa solo il 18/19 % dei deportati.
Al momento della deportazione di Raul la moglie Concetta aveva 39 anni, la figlia Franca, che era la maggiore dei tre figli, aveva 14 anni, l’altra figlia Atusca aveva 9 anni e il figlio minore Giancarlo aveva 5 anni.
Con la deportazione di Raul, che era l’unico sostentamento, la famiglia dovette sopportare anche grossi problemi economici.
La figlia Franca, ancora giovanissima, dovette cercarsi un lavoro per mandare avanti la famiglia.
Questo tragico evento condizionò moltissimo la vita familiare.
L’ultimo anno di guerra e molti anni successivi furono veramente molto duri e tristissimi.